Il mio amore per gli Yes iniziò un pomeriggio di Febbraio del 1991, tra gli espositori dei cd di un negozio della Ricordi. Raccontare il come ed il perché sarebbe noioso e ci porterebbe drammaticamente lontani dal motivo per il quale mi trovo ora a scrivere. Posso solo riferire che si trattò di un provvidenziale imprevisto dal momento che, in precedenza (lo ammetto vostro onore), avevo sempre provato un sincero ed inspiegabile fastidio per il timbro di Jon Anderson ma quel pomeriggio, ad un passo dai miei 17 anni, And You And I fece evaporare ogni ingiustificata reticenza. D’altro canto, si sa, i grandi amori, spesso, cominciano proprio con una vampata di epidermica antipatia. Il caso volle che gli eventi sin qui riferiti accadessero proprio a ridosso dell’uscita del controverso Union e del relativo tour che avrebbe visto sul palco, per la prima volta insieme, le line up di Close To The Edge e di 90125. La data romana del 12 Giugno brillò grazie al divertito funambolismo di un eterogeneo ensemble che non si risparmiò per un solo istante, regalando ai presenti il lusso di un ricordo non ripetibile.

Ieri sera, sul palco de La Nuvola di Roma, la cose, purtroppo, sono andate in modo completamente differente. A parte la ragione sociale (ridotta a brand vintage, liberamente associabile a musicisti ormai totalmente fungibili) e la presenza di Steve Howe, non si intravedono validi motivi per parlare di “band storica”. Complice la presenza di Geoff Downes, unico altro nome imparentato con i ’70s ed in vistoso affanno nel ruolo che fu di Wakeman, la formazione attuale, nel migliore dei casi, ricorda uno spin off in tono minore degli Asia mentre, nel peggiore, finisce col somigliare alla cover band di sé stessa. Quello degli Yes non è certo un caso isolato. Per onestà intellettuale bisogna ammettere che il fenomeno delle band “classiche” impegnate nel tenere a bada (per questioni aziendali) le leggi della biologia è così diffuso da essere ormai sotto gli occhi di tutti ed una lista di ulteriori esempi sarebbe davvero troppo lunga per trovare posto in questa sede. Si tratta di un effetto collaterale della storicizzazione del rock col quale, nei prossimi anni, avremo a che fare con sempre maggior frequenza.
L’intento di voler quindi preservare il patrimonio genetico di una band si scontra oggi con gli insormontabili paradossi creati da un passato che andrebbe consegnato ai libri di storia invece di essere costretto a (ri)vivere nell’animazione sospesa di una pura rappresentazione scenica in odore di fan service.
Tornando al nostro caso specifico, é poi evidente che la pur rispettabile e diligete solerzia di Jon Davison non potrà mai supplire all’incolmabile assenza della voce di Anderson. Anche Jey Schellen, dietro alla batteria, fa del suo meglio per riprodurre quella coesione di cui solo Alan White era capace. Il suo volenteroso zelo è professionalmente encomiabile ma non basta ad evitare che il drumming si palesi come l’anello più debole della performance. Il basso di Billy Sherwood, ex leader dei World Trade (recuperate il loro omonimo esordio del 1989) e già ufficialmente in formazione (come chitarrista) nei tardi ‘90s, può vantare una designazione alla successione ricevuta direttamente dalle mani del compianto Squier, segno inequivocabile di un apporto professionale di alto profilo.

Il ruolo di maestro delle cerimonie e direttore d’orchestra spetta invece ad un Howe al cui indiscutibile blasone manca ormai la fluidità dei giorni migliori. La sensazione, duole constatarlo, è quella di assistere ad una rappresentazione teatrale di “quel” noto romanzo di Mary Shelley. In una venue ben lontana dal sold out, si consuma così un rituale da Madame Tussauds, fatto di caparbia nostalgia che sfiora l’accanimento terapeutico. La discutibilità di un progetto nel quale nessuno dei membri originali é coinvolto, le ripetute cancellazioni del tour e la indifendibile debolezza degli ultimi album (esaltata da una produzione non in linea con la legacy del nome Yes) devono aver contribuito a demotivare una buona fetta del pubblico di riferimento.
Bastano pochi minuiti dall’apertura, affidata ad una proattiva Machine Messiah, per provare qualche goccia d’imbarazzo non certo per i musicisti (professionali, sebbene algidi e scolastici) ma per un pubblico che si accontenta degli amabili resti di un marchio un tempo prestigioso, invece di investire in solide realtà del prog contemporaneo. La scelta del primo brano, estratto da Drama, l’album del ’79 con i due Buggles (Trevor Horn e Downes) al posto di Anderson e Wakeman, spoilera subito gli intenti di una set list che sceglie di rovistare tra gli episodi meno ovvi di una carriera ormai prossima al sessantesimo anniversario. Lo scopo é chiaramente quello di far leva sulle lusinghe degli easter egg per continuare ad attrarre un pubblico anagraficamente impigrito e sempre meno interessato.
Con It Will Be A Good Day (The River) viene addirittura recuperato uno degli episodi più riusciti del dignitoso The Ladder (1999). A fine serata sarà questo il brano con il quale i musicisti avranno dimostrato una maggior empatia. La sequenza di Going For The One e I’ve Seen All Good People porta a spasso il pubblico sul sentiero di un breve ma appagante greatest hits ed Howe, rivolgendosi ad una platea che reagisce con comprensibile freddezza, sfoggia tutto il più prevedibile repertorio di complimenti a base di pizza, sole e mandolino.

Con Time And A World si materializza, invece, il solo episodio della serata dedicato alla produzione precedente all’ingresso in formazione del chitarrista. L’arrivo di una breve versione strumentale di America, cover del celebre brano di Simon & Garfunkel, mi lascia con un velo di perplessità ed il punto interrogativo sul mio volto si ingigantisce appena attacca Don’t Kill The Whale, singolo con nobili intenti ambientalisti, ma dalla debole identità (non a caso pubblicato in piena esplosione Punk) estratto da un album irrisolto e prescindibile come Tormato (1978).
L’etera consistenza di Turn Of The Century, uno dei vertici interpretativi del catalogo con Anderson, al quale Davison si applica con genuino rigore, è il congedo ideale prima di una breve pausa. Al rientro, affidato a Southside Of The Sky, un senso di fatica inizia a bussare alla porta di quel che resta del mio entusiasmo.
E’ ormai chiaro che mi trovo a vivere un’esperienza personalmente dolorosa, sotto il profilo non solo affettivo ma anche storico culturale. Cut From The Stars, dall’ultimo, dimenticabile, Mirror To The Sky, rincorre un cliché ormai irraggiungibile e suona come un obbligo autoimposto, alla cui necessità gli stessi musicisti credono ben poco. La mazzata vera arriva però con la versione neofilizzata di Tales From Topographic Oceans che, anche in questa veste opportunamente più concisa, continua a mostrare tutte le autoindulgenti debolezze che ne hanno fatto, col tempo, un insostituibile esempio dei deleteri eccessi ai quali era giunto il Prog.
A fare le veci di un necessario defibrillatore ci sono, per fortuna, Roundabout e Starship Trooper. Il loro ingessato entusiasmo non è però in grado di resettare il severo giudizio sull’intera serata.
Fa male constatarlo ma gli Yes di Howe non sono altro che un’impresa itinerante a conduzione familiare. Resta il profondo rammarico non solo per un glorioso nome del rock dato in subappalto con imperdonabile leggerezza, ma anche per due ore della propria vita scaraventate giù da un ponte e trascorse in (distopica) compagnia di un pubblico vacuamente nostalgico, accorso per acquistare i prodotti di una griffe che ha smarrito il prestigio di un tempo.
Setlist
1. Machine Messiah
2. It Will Be a Good Day (The River)
3. Going for the One
4. I’ve Seen All Good People
5. America (Simon & Garfunkel cover)
6. Time and a Word
7. Don’t Kill the Whale
8. Turn of the Century
9. South Side of the Sky
10. Cut From the Stars
11. The Revealing Science of God (Dance of the Dawn) / The Remembering (High the Memory) / The Ancient (Giants Under the Sun) / Ritual (Nous sommes du soleil)
12. Roundabout
13. Starship Trooper
Testo di Manuel Nash
Fotografie di Chiara Lucarelli
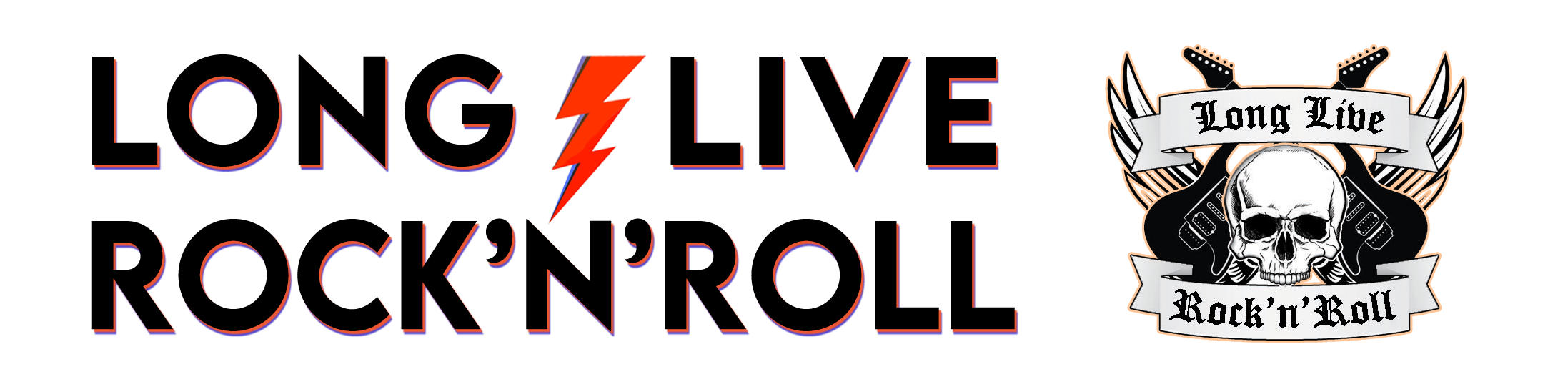





















Comments are closed.